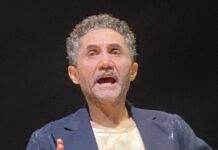Il miracolo di San Gennaro si è rinnovato. Poco prima delle 17, nella Cappella di San Gennaro del Duomo di Napoli, l’ampolla contenente il sangue del Santo è stata aperta e il contenuto è apparso già liquido. Presenti all’apertura il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, presidente della Deputazione della Real Cappella del Tesoro, monsignor Vincenzo De Gregorio, abate della Cappella, e i vescovi ausiliari di Napoli Francesco Beneduce e Michele Autuoro, quest’ultimo in rappresentanza dell’arcivescovo don Mimmo Battaglia, impegnato a Roma in vista del Conclave.
L’annuncio ufficiale dello scioglimento del sangue è stato dato alle 18.09 nella basilica di Santa Chiara, al termine della tradizionale processione. A pronunciare le parole tanto attese è stato monsignor Francesco Beneduce: “Il prodigio è avvenuto e ringraziamo Dio”, ha detto, accolto da un lungo applauso dei fedeli.
Un miracolo che si ripete tre volte l’anno
Lo scioglimento del sangue di San Gennaro avviene in tre momenti dell’anno: il 19 settembre, giorno del martirio del Santo; il 16 dicembre, anniversario del miracolo “laico” che fermò l’eruzione del Vesuvio nel 1631; e il sabato che precede la prima domenica di maggio, in memoria della traslazione delle reliquie.
Questo evento di maggio è l’unico a data mobile e rievoca la prima traslazione del corpo del Santo da Pozzuoli – dove fu decapitato – a Napoli, fino alle Catacombe di Capodimonte. La processione, che accompagna il rito, parte dal Duomo e attraversa le strade del centro storico della città, terminando nella basilica di Santa Chiara, dove si celebra l’eucaristia.
Una tradizione millenaria tra fede, folclore e paura
Il corteo che accompagna il Santo è detto anche “processione degli infrascati”, per via della tradizione del clero di coprirsi il capo con corone di fiori per proteggersi dal sole. I fedeli si accalcano lungo il percorso, e decine di volontari dell’arcidiocesi, della protezione civile e forze dell’ordine garantiscono ordine e sicurezza. Anche la fanfara dei carabinieri è presente per onorare l’evento.
Tra i fedeli, anche molti turisti provenienti da ogni parte del mondo, raccolti davanti alla teca e all’iconica “faccia gialla” del Santo per pregare, osservare, e – soprattutto – sperare.
Il segno del mancato miracolo e i presagi funesti
Nel corso dei secoli, la mancata liquefazione del sangue è stata letta come un presagio nefasto. Il prodigio non si verificò nel 1939 e 1940, anni della Seconda Guerra Mondiale e dell’ingresso dell’Italia nel conflitto. Neanche nel 1943, l’anno dell’armistizio Badoglio e dell’occupazione nazista di Napoli.
Ancora, il sangue restò solido nel 1973, durante una gravissima epidemia di colera che colpì la città; nel 1980, anno del terremoto dell’Irpinia; e nel 2020, con lo scoppio della pandemia da Covid-19. Questi episodi hanno alimentato il legame tra la liquefazione e la sorte della città, tra miracolo e superstizione, fede e paura.
Le parole del vescovo Beneduce: un appello alla speranza
Durante l’omelia a Santa Chiara, monsignor Francesco Beneduce ha rivolto un accorato appello al sindaco e alla comunità: «Sindaco, teniamo presente i nostri giovani, guidiamoli. Possono armarsi, possono farsi del male. Le difficoltà della nostra città le conosciamo… Ci sono tante notti buie, di chi cerca casa, lavoro, chi si sente solo. Ma da queste situazioni possono arrivare momenti belli, al nuovo mattino, consapevoli che Dio è luce».
Un messaggio che unisce la dimensione spirituale del miracolo a quella sociale e civile della città, dove la fede continua a rappresentare, per molti, una bussola di speranza.