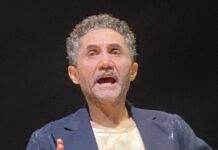L’intera comunità scientifica internazionale plaude all’organizzazione della conferenza “Pompei · 79 d.C. – questioni di metodo e di narrazione storica”, svoltasi all’Antiquarium di Boscoreale e negli scavi più recenti di Pompei. L’evento, ideato dall’archeologa Helga Di Giuseppe in collaborazione con il Parco Archeologico di Pompei, la casa editrice Scienze e Lettere e l’Archeoclub d’Italia, ha riunito per la prima volta esperti di archeologia, filologia, paleobotanica, paleoclimatologia e altre discipline per discutere la datazione dell’eruzione del Vesuvio.
La conferma della data dell’eruzione: 24 agosto 79 d.C.
Dopo un intenso dibattito multidisciplinare, è stata confermata la tradizionale data dell’eruzione: 24 agosto 79 d.C., come raccontato da Plinio il Giovane nelle sue lettere a Tacito inviate meno di 30 anni dopo il cataclisma.
Secondo Di Giuseppe, sono stati definitivamente esclusi:
-
la moneta interpretata erroneamente;
-
l’iscrizione a carboncino, priva di elementi datanti certi;
-
le date alternative del 24 ottobre e del 23 novembre, generate da errori nella trasmissione dei codici della lettera di Plinio.
Il filologo Pedar Foss, dopo uno studio di 9 anni, ha dimostrato che le lettere più attendibili riportano il termine nonum kalendas Septembres, cioè il 24 agosto, confermando così la versione tradizionale.
Un modello scientifico senza precedenti
La conferenza ha messo in evidenza Pompei come modello scientifico interdisciplinare unico al mondo. Gli studiosi hanno analizzato dati archeologici, letterari e climatici per comprendere meglio il contesto dell’eruzione, dai ritrovamenti alimentari alle pratiche agricole e religiose dell’epoca.
Di Giuseppe ha sottolineato:
“Non si tratta più di cercare una data piegando i dati, ma di capire il contesto storico, climatico e sociale dei Pompeiani: cosa raccoglievano, come vestivano e quali festività celebravano nei giorni dell’eruzione.”
L’interdisciplinarità al centro del dibattito
Gli interventi hanno evidenziato l’importanza di un approccio multidisciplinare:
-
Eric Moormann (Università di Nijmegen): “Per la prima volta si sono incontrate discipline diverse, dalle Lettere Classiche alle Scienze, aprendo un nuovo percorso di confronto.”
-
Antonio De Simone, archeologo: “Occasioni come questa rappresentano una fase di crescita culturale fondamentale.”
-
Paolo Giulierini: “Il convegno è un esempio di metodo: le scienze devono dialogare tra loro per raggiungere risultati più completi.”
Il ruolo dell’Archeoclub d’Italia
Rosario Santanastasio, presidente nazionale, ha dichiarato:
“Grazie al Parco Archeologico e a Helga Di Giuseppe, siamo riusciti a coinvolgere l’intera comunità scientifica, creando un confronto tra discipline diverse.”
Anche l’avv. Michele Martucci, coordinatore regionale, ha sottolineato l’importanza dell’interdisciplinarità: “Il convegno ha messo insieme archeologi, geologi, numismatici e specialisti in ricerca estratigrafica, andando oltre la sola questione della datazione dell’eruzione.”
Un futuro di ricerca condivisa
L’evento segna un punto di svolta nella ricerca su Pompei, ponendo le basi per nuovi studi multidisciplinari e confronti scientifici. È previsto un possibile documento conclusivo che sintetizzerà i risultati della conferenza.
Il Comitato scientifico e organizzativo era composto da: Gabriel Zuchtriegel, Stefano De Caro, Nathalie de Haan, Helga Di Giuseppe, Paolo Giulierini, Mario Grimaldi, Eric M. Moormann, Domenico Palumbo, Umberto Pappalardo, Felice Senatore.